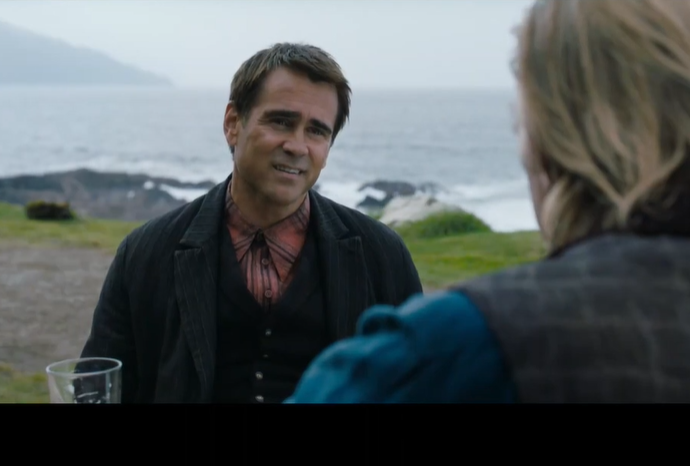Briciole di normalità e una nuova speranza nell’umanità
di Natanail Danailov
L’ultima edizione de Gli incontri di PensarBene è stata ospitata dell’associazione Family Way APS di Paese (TV). Silvia Grigolin – socia fondatrice e attuale Presidentessa – è stata entusiasta sin dal primo momento in cui le abbiamo proposto di organizzare l’incontro: poiché la sua associazione abbraccia appieno tutti i nostri valori e pensieri su tematiche a noi care – in particolare il rapporto tra la comunità e le persone, tema affrontato e discusso da PensarBene nel corso del tempo con articoli, approfondimenti e altri incontri online – ci è sembrata una buona occasione per analizzare, studiare e sentirci raccontare dal vivo di un caso che affronta in prima persona questi argomenti.Continua