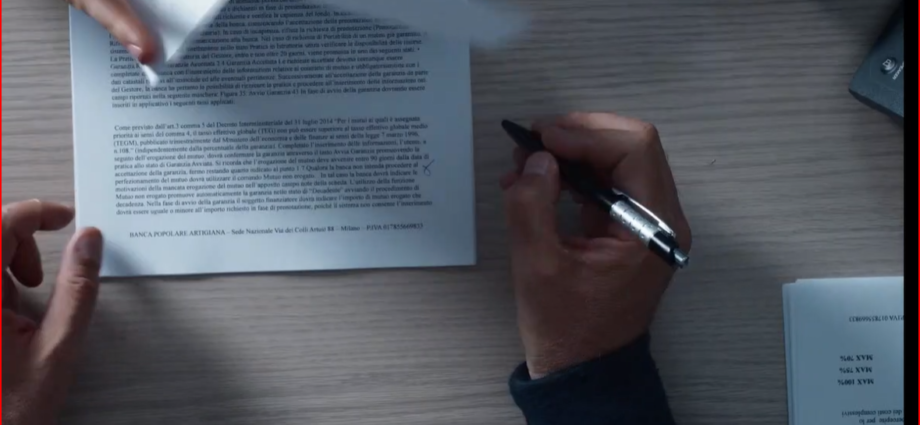Consigliati da PensarBene: “Cento Domeniche”
di Bruno Perazzolo
E’ possibile una giustizia che prescinda dal bene? Dal film di Antonio Albanese una storia esemplare di separazione tra élite e popolo e di declino della morale laica.
Antonio ha lavorato tutta la vita con passione e competenza ………….. prepensionato …………….. fa da tutor a giovani apprendisti nella stessa azienda nella quale ha esercitato, per decenni, la professione come dipendente……………. Antonio è, quel che si dice, “una normale, positiva persona” …………….. Si fida dell’imprenditore ……………. della “banca popolare locale” …………….. della giustizia e dello Stato …………… e del futuro ………………. Ma ecco che il matrimonio della figlia, gli farà scoprire una realtà inattesa e del tutto diversa.