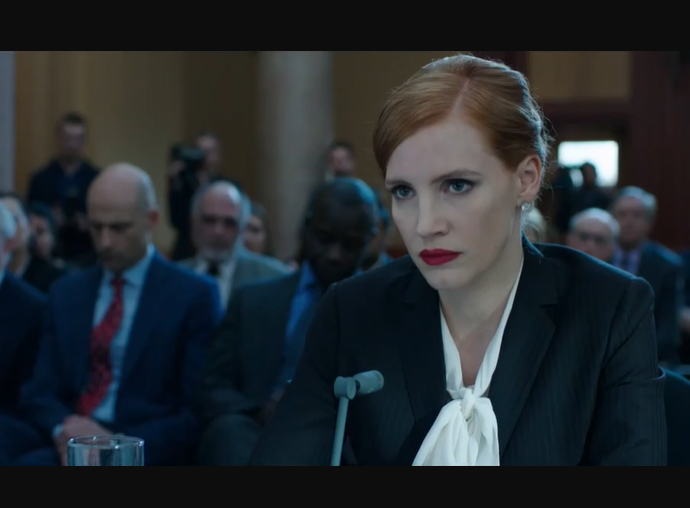Come ci poniamo di fronte alle guerre
di Dario Nicoli
Qualche giorno fa, ad un amico che mi chiedeva come sarebbe stato il 2024, ho risposto istintivamente “dipende dalle guerre”. Ripensandoci in seguito, mi sono accorto che questa prospettiva cambia il modo normale di fare previsioni, basato sulle tendenze statistiche degli anni precedenti, come se il futuro non fosse nient’altro che l’aggiunta di un tassello ad un lungo periodo di progresso in tutti i campi della vita, la tipica illusione dell’illuminismo, avvero l’ultima grande religione civile fondata su razionalità, tolleranza, altruismo ed aspirazione alla libertà. Se la crisi economica del 2007-2014 è da considerare come un’interruzione momentanea di questo lungo ciclo, se la pandemia ha incrinato la fiducia in questa visione, sono state le guerre a rompere del tutto l’incantesimo e ad imporci di comprendere questo punto cruciale della nostra storia in cui siamo coinvolti non da pochi anni, anche se non ce ne siamo resi conto se non con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, iniziata dal febbraio del 2014.
Cosa significa pensarbene in questo momento?Continua