per quale motivo, mentre il centralismo può permettersi di lasciare “la scuola di tutti al margine”, il federalismo deve necessariamente porla “al centro”

Video di steve diaz da Pixabay
Bruno Perazzolo
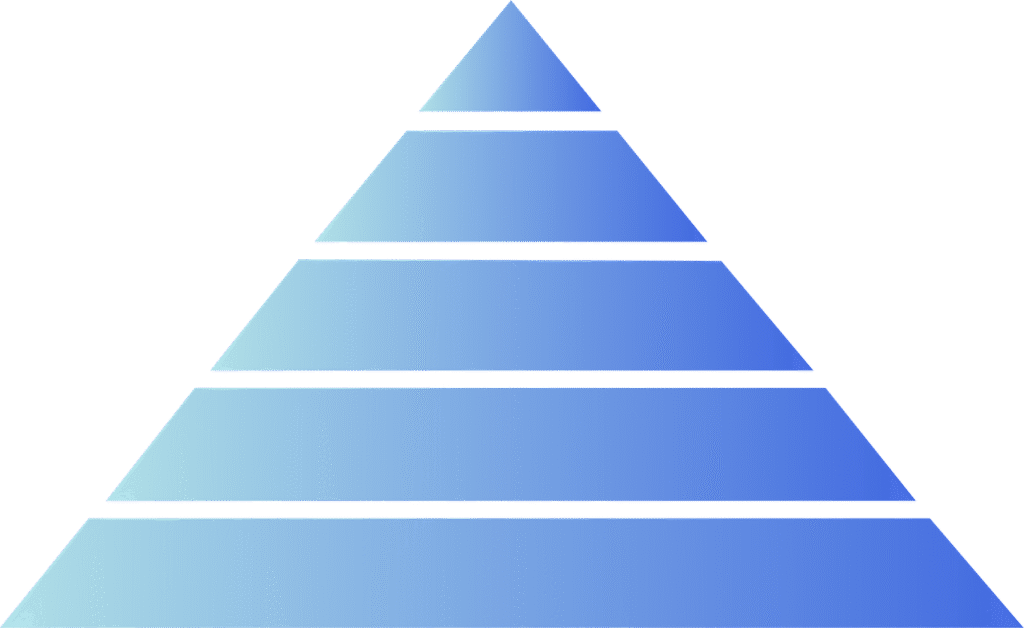
Foto di Clker-Free-Vector-Images da Pixabay
La piramide è l’icona, la metafora, il tipo ideale del sistema centralista-burocratico-fordista. Al vertice sta la legge e poi, man mano che si scende di livello, incontriamo chi, entrando sempre di più nel dettaglio, esegue quanto previsto da regolamenti sempre più particolareggiati. In altri termini, in cima alla piramide si trova il decisore politico, il “gesto volontaristico” di chi detta la direzione da seguire esercitando, di norma, un notevole grado di arbitrio. A partire dal livello apicale, tutto diventa solo una questione tecnica, di massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza. Insomma, una questione di pura razionalità che, man mano che si scende, si parcellizza sempre di più cosicchè, alla fine, chi sta in fondo, chi opera nell’ultimo gradino, quasi sempre non riesce neppure a comprender quanto sta facendo ed agisce per adempimenti. Il modello della piramide è, pertanto, anche un modello del sapere e della capacità di cogliere il senso del proprio fare. La cultura scolastica è in mano ad una minoranza di intellettuali e di funzionari che vivono entro un mondo tutto loro, che non riconoscono il valore culturale della dedizione di chi si impegna a favore degli altri, della maestria di chi cerca di fare al meglio la sua parte, del pensiero radicato nei territori, cioè della saggezza del popolo. Il continuo profluvio di riforme e innovazioni non tiene neppure conto della storia e delle qualità delle scuole reali, che si trovano quindi ad operare come se dovessero aggiungere sempre qualcosa, producendo così un senso di alienazione, derivato dal non riconoscersi in ciò che fanno.
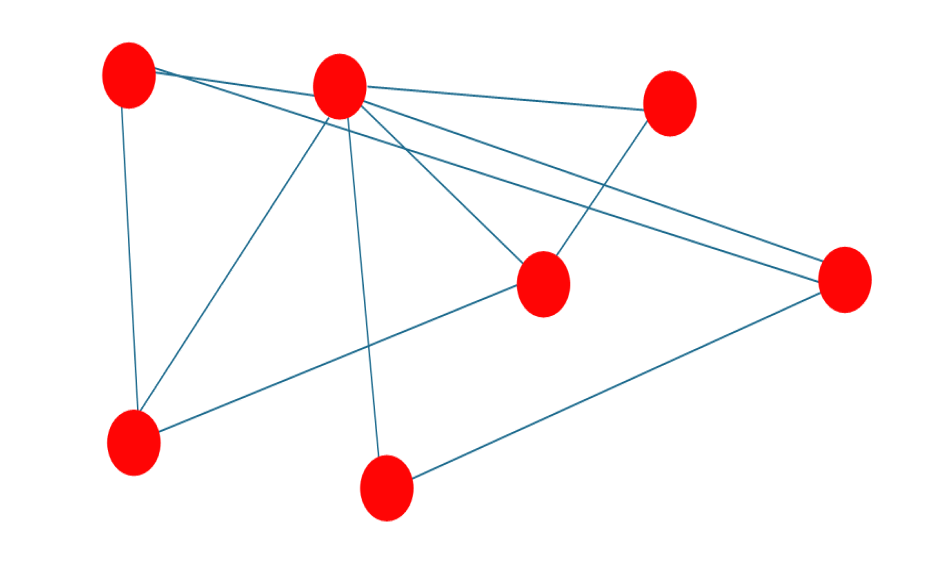
Questa, invece, è l’immagine ideale di una struttura policentrica o multicentrica di tipo federale. Ciò che maggiormente risulta affine allo spirito comunitario e democratico. Come si può vedere i centri decisionali sono molteplici. Concettualmente, la periferia sparisce con un doppio risultato: la cultura, la scuola che conta, il sapere, le competenze anziché essere concentrate in un punto, sono diffuse ovunque, non come un “innesto” dall’alto, ma come “fatto esistente” che va riconosciuto e valorizzato come patrimonio culturale dell’intero territorio e di coloro che lo abitano. Uno Stato umile (e intelligente) è quello che si pone al servizio di una comunità di comunità nelle quali “il sangue riprende a circolare nel cervello di tutti”. Tutti hanno modo di trovarsi in un qualche centro e, pertanto, di agire più umanamente, di agire come una persona dentro una comunità che, “responsabile della propria scuola e responsabile del proprio futuro”, comprende il senso di quello che fa.
“Federalismo culturale” è il titolo del breve testo di Denis de Rougemont del 1963. Il libro altro non fa che riportare il contenuto di una conferenza tenuta dall’autore, nel medesimo anno, all’Università di Neuchâtel, non a caso nel cuore della sua Svizzera, patria del federalismo. Poche pagine in cui si chiarisce magistralmente come il vero fondamento dell’autonomia e dell’autogoverno dei popoli sia la cultura, ovvero, in senso lato, anche e soprattutto, una “scuola di tutti perché scuola diffusa”. Ma come fare a “restituire la scuola alla comunità locale” affinchè questa torni a vivere più umanamente? Le parole chiave sono: AUTONOMIA, LEGAME CON IL TERRITORIO, PERSONALIZZAZIONE.
Nel 1997, sospinta dall’impeto leghista “del vento del nord”, fu approvata la legge quadro sull’autonomia scolastica (nota come legge Bassanini) che, nel 1999, diede il là al relativo regolamento attuativo del Ministro alla Pubblica Istruzione, Giovanni Berlinguer. Quando si dice una riforma piena di buoni propositi, ma priva dei più elementari requisiti, a proposito dell’autonomia scolastica si è detto tutto sia riguardo ai suoi modesti sviluppi sia al suo epilogo, nel complesso deprimente. Due sono i fattori che, incredibilmente, sono mancati entro un impianto pretenzioso, pensato come una sorta di rivoluzione capace di appiattire la verticalità del sistema di Istruzione e Formazione italiano: 1) il reclutamento, la gestione della carriera di docenti e manager (Dirigenti Scolastici) a livello quantomeno locale (regionale o provinciale) se non, addirittura, della singola Istituzione scolastica e/o formativa; 2) l’autonomia finanziaria assicurata da risorse trattenute a livello regionale. Ciò detto, resta il valore dell’autonomia come unica, vera chiave di volta per una scuola restituita alla comunità locale a condizione che essa, l’autonomia, comprenda anche quei “fattori mancanti”, appena citati, la cui assenza, sino ad oggi, ne ha determinato il sostanziale fallimento.
Nel 2004, con legge 53/2004, venne introdotta l’alternanza scuola lavoro dal 2019 “evolutasi” in PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Quando mi capita di parlarne con i colleghi ancora in servizio, il giudizio sull’esito di questo sviluppo è innominabile. Si parlò, allora, pomposamente, di legame con le imprese e, successivamente, con i PCTO, di legame con il territorio. Ancora una volta, però, i “conti si fecero senza l’oste”. Suonava bene, era una bella, era una grande novità e questo bastò ad imbastire convegni su convegni e corsi di formazione su corsi di formazione senza interrogarsi su una questione tanto semplice quanto fondamentale: è in grado una struttura centralista di rispondere alle esigenze di partecipazione e coinvolgimento del territorio che stanno alla base di ogni solido e duraturo legame comunitario locale? La domanda è chiaramente retorica e spiega bene la generale disaffezione che aleggia attualmente nella scuola riguardo a tutto ciò che si intende come “apertura al territorio”. Cionondimeno sfido chiunque, a fronte di una scuola veramente autonoma, a trovare qualcosa di meglio. Studiando i rari casi in cui, per una serie di fortuite combinazioni, s’è riusciti a farne una buona pratica, s’è infatti evidenziato come, l’alternanza di apprendimenti in aula e fuori dall’aula, dal libro e dalla mano, abbia dato costantemente risultati a dir poco esaltanti soprattutto in rapporto agli allievi “più fragili”.
Infine, la personalizzazione dei curricoli. Un altro mantra della scuola italiana che da decenni si va ripetendo e che, nella sua attuazione pratica, sembra essere, alla fine, sfociato in un mare di procedure, scartoffie e “progetti inclusivi” che, unitamente all’impatto omologante delle discipline sulla didattica, sembra abbia prodotto un esito paradossale: più si afferma di personalizzare, più i curricoli si rendono impersonali. Servirebbe ridurre la burocrazia, servirebbe ridurre il peso della didattica generale incentrata su una lista infinita di contenuti e di competenze per lasciare maggiore spazio alla cura delle carenze e al potenziamento delle eccellenze. Tutte buone pratiche che, di nuovo, solo una scuola realmente responsabile ed autonoma può sviluppare e conservare trasmettendole alle generazioni future dei propri docenti e dirigenti: nuovi “maestri” che potranno, allora sì, subentrare ai colleghi “in uscita”, poggiando sulle spalle di una tradizione gelosamente conservata e resa feconda nei tempi nuovi.
Concludendo. Se la scuola centralista di massa appare, per ragioni strutturali, sempre più declinante e marginalizzata, la scuola affine al modello policentrico – federalista sembra essere, all’opposto, la pietra angolare dell’intero sistema. In altre parole, la scuola di comunità che tornano a vivere.